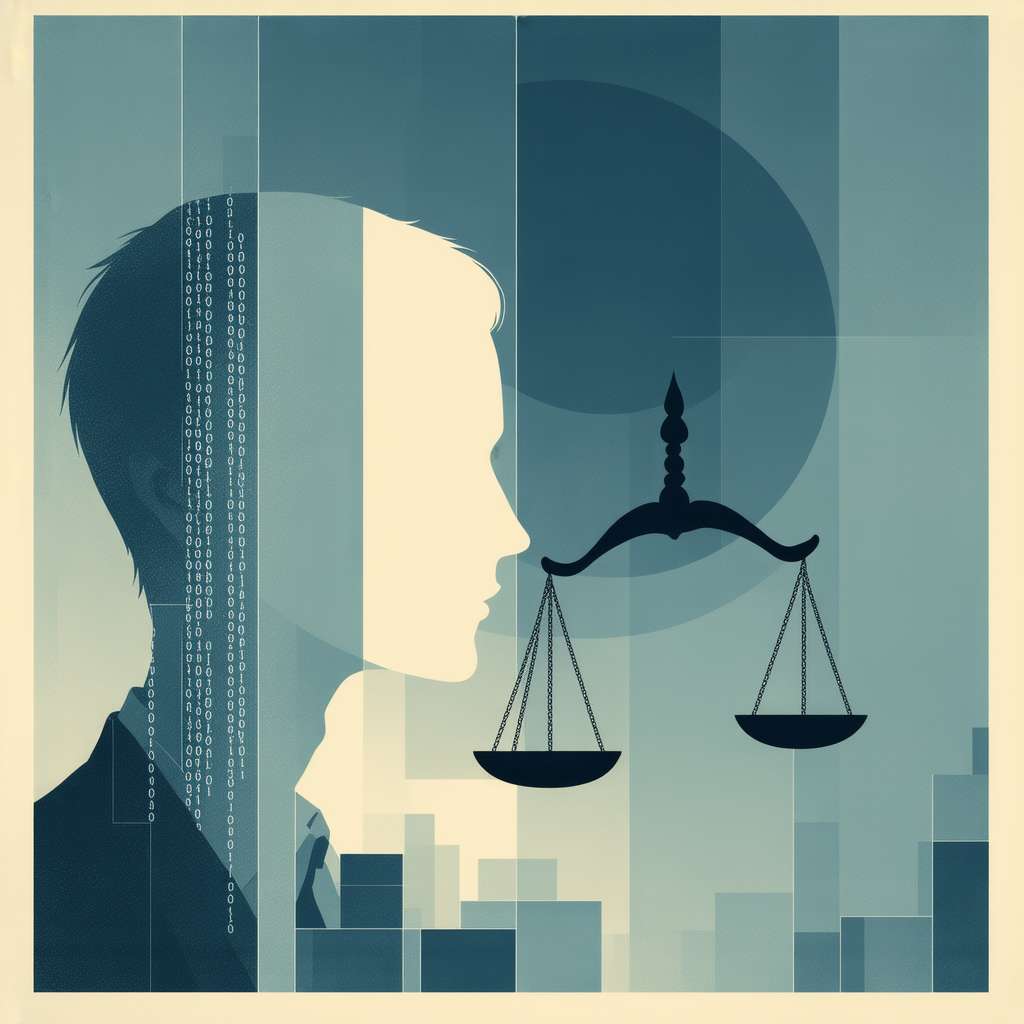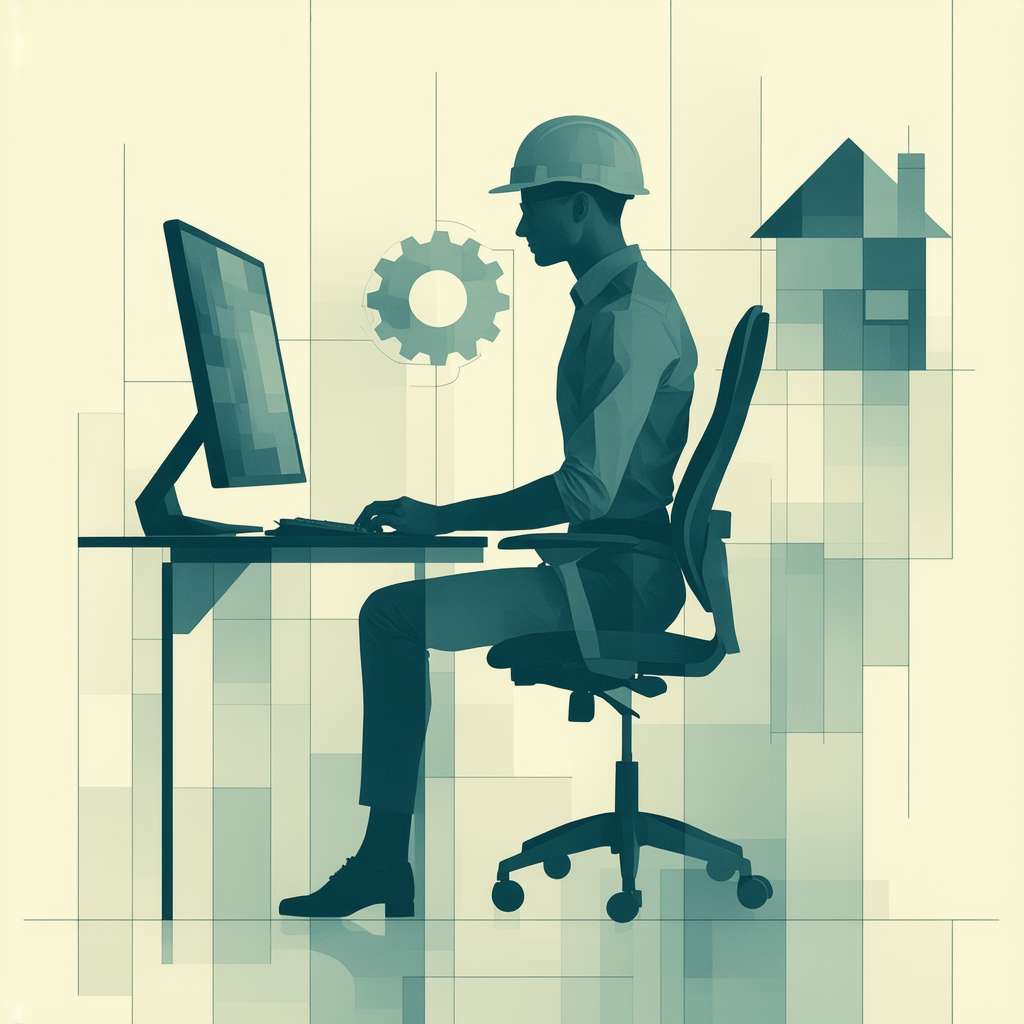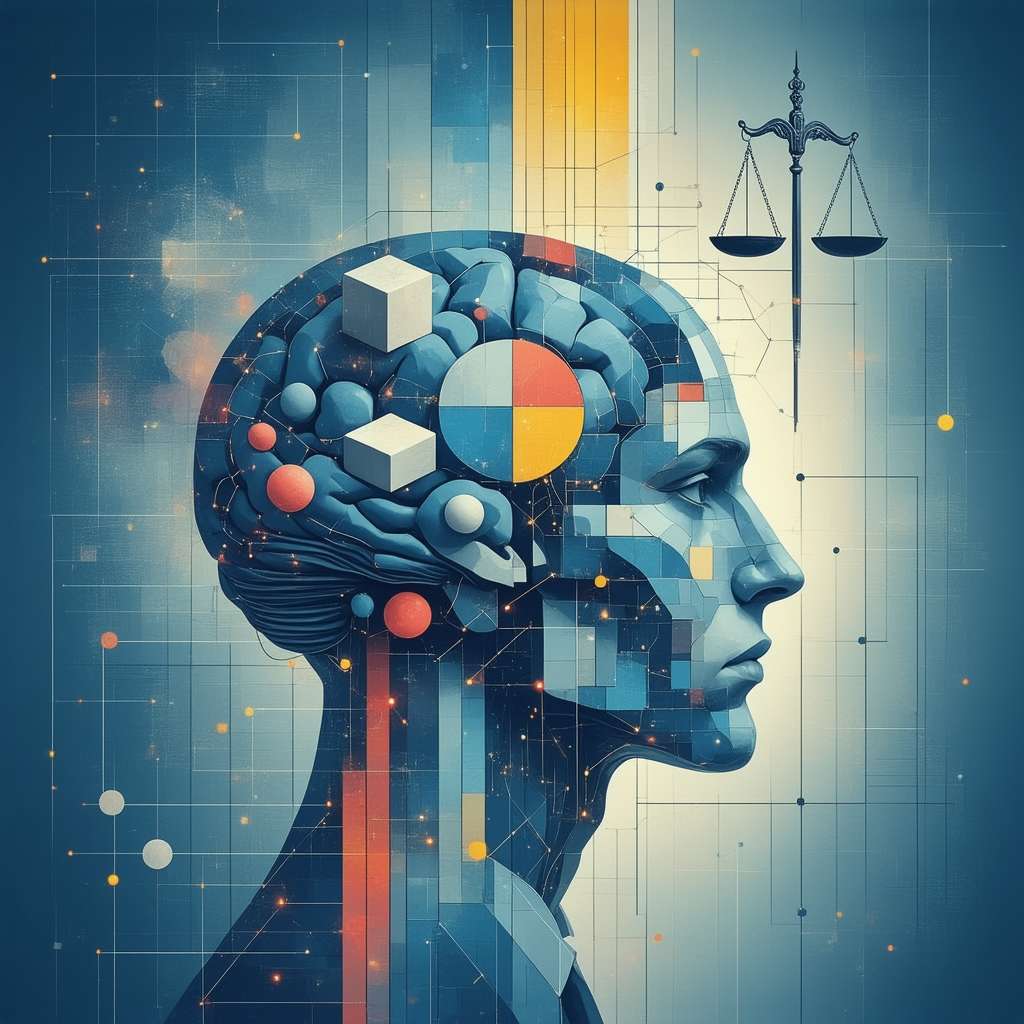E-Mail: [email protected]
- Il GDPR dal 2018 sancisce il diritto alla cancellazione dei dati.
- Sentenza Google Spain: motori di ricerca responsabili della deindicizzazione.
- In Italia, legge sul diritto all'oblio oncologico dal 2023.
- Guariti dal cancro: oblio dopo 10 anni (o 5 se <21).
Una Prospettiva Italiana ed Europea
Il diritto all’oblio nell’era digitale
Il mondo digitale, per sua natura, non dimentica. Ogni interazione, ogni dato condiviso, ogni contenuto pubblicato lascia una traccia indelebile, potenzialmente accessibile per un tempo indefinito. In questo scenario, il diritto all’oblio emerge come un diritto fondamentale, volto a tutelare la dignità e la riservatezza degli individui di fronte alla pervasività della memoria digitale. La questione centrale è dunque: come bilanciare la libertà di informazione e la necessità di preservare la sfera privata in un contesto in cui il passato digitale può perseguitarci per sempre?
Il diritto all’oblio si configura come la facoltà di un individuo di non rimanere esposto, a tempo indeterminato, alle conseguenze negative derivanti dalla diffusione di informazioni che lo riguardano, anche se queste informazioni sono state, in origine, divulgate legittimamente. Si tratta, in sostanza, del diritto di controllare la propria identità digitale, di impedire la riproposizione di fatti o circostanze che non riflettono più la realtà attuale della persona, o che possono arrecare un pregiudizio ingiustificato alla sua reputazione. Il concetto si ricollega all’idea di poter lasciare alle spalle errori passati, difficoltà superate o semplicemente scelte di vita che non appartengono più al presente.
La genesi del diritto all’oblio affonda le radici nella crescente consapevolezza dei rischi connessi alla digitalizzazione della società. L’avvento di internet e dei social media ha amplificato enormemente la capacità di memorizzazione e di diffusione delle informazioni, rendendo sempre più difficile per gli individui esercitare un controllo effettivo sulla propria immagine pubblica. La pubblicazione, anche involontaria, di dati sensibili, la diffusione di notizie imprecise o tendenziose, la riproposizione di eventi negativi del passato possono compromettere seriamente la vita personale e professionale di un individuo, limitandone le opportunità e pregiudicandone la serenità.
La tutela del diritto all’oblio si pone, tuttavia, in un delicato equilibrio con altri diritti fondamentali, quali la libertà di espressione e il diritto all’informazione. La necessità di garantire un’informazione completa e accurata, la tutela della memoria storica e la libertà di manifestazione del pensiero possono giustificare, in alcuni casi, la permanenza online di informazioni che riguardano un individuo, anche se questi desidera che vengano rimosse. Il compito del legislatore e dei giudici è quindi quello di individuare un punto di equilibrio tra questi interessi contrapposti, definendo i limiti e le condizioni in cui il diritto all’oblio può essere esercitato.
- Finalmente una legge che tutela la nostra dignità digitale!👏......
- Il diritto all'oblio? Un'utopia in un mondo iperconnesso 🌐......
- Ma il diritto all'oblio non rischia di riscrivere la storia 🤔......
Il quadro normativo italiano ed europeo
In Italia, il diritto all’oblio non è espressamente previsto da una legge specifica, ma si fonda su una serie di norme costituzionali e legislative che tutelano la dignità, la riservatezza e l’onore della persona. Tra queste, un ruolo centrale è svolto dall’articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, e dall’articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza e vieta ogni forma di discriminazione. La giurisprudenza italiana ha progressivamente elaborato il concetto di diritto all’oblio, definendolo come il diritto di un individuo di non rimanere esposto a tempo indeterminato alle conseguenze negative derivanti dalla riproposizione di notizie che lo riguardano, anche se queste notizie sono state, in origine, divulgate legittimamente.
Un importante passo avanti nella tutela del diritto all’oblio è stato compiuto con l’introduzione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 2018. L’articolo 17 del GDPR riconosce espressamente il “diritto alla cancellazione” (“diritto all’oblio”), stabilendo che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano determinate condizioni. In particolare, il diritto alla cancellazione può essere esercitato quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, quando l’interessato revoca il consenso al trattamento, quando si oppone al trattamento per motivi di marketing diretto, quando i dati sono stati trattati illecitamente, o quando la cancellazione è necessaria per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro.
Il GDPR prevede, tuttavia, alcune eccezioni al diritto alla cancellazione, volte a bilanciare questo diritto con altri interessi meritevoli di tutela. In particolare, la cancellazione dei dati non è obbligatoria quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
La giurisprudenza europea ha contribuito in modo significativo a definire i contorni del diritto all’oblio, in particolare con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Google Spain (2014). La Corte ha affermato che i gestori dei motori di ricerca sono responsabili del trattamento dei dati personali contenuti nelle pagine web che indicizzano, e che quindi possono essere obbligati a rimuovere dai risultati di ricerca i link a pagine web che contengono informazioni obsolete o lesive della reputazione di un individuo, qualora sussistano determinate condizioni. Questa sentenza ha avuto un impatto significativo sull’applicazione del diritto all’oblio online, aprendo la strada a numerose richieste di deindicizzazione da parte di cittadini europei.

L’applicazione del diritto all’oblio e le sue sfide
L’applicazione pratica del diritto all’oblio si rivela spesso complessa e problematica, soprattutto nel contesto del web. La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Google Spain ha segnato un punto di svolta, attribuendo ai motori di ricerca un ruolo attivo nella tutela della privacy degli individui. Tuttavia, questa decisione ha anche sollevato una serie di interrogativi e di difficoltà operative.
Innanzitutto, la definizione di “informazione obsoleta o lesiva della reputazione” è tutt’altro che univoca. I motori di ricerca si trovano spesso a dover valutare se una determinata informazione sia ancora di interesse pubblico, o se la sua permanenza online possa arrecare un pregiudizio ingiustificato all’interessato. Questa valutazione richiede un bilanciamento delicato tra il diritto all’oblio e il diritto all’informazione, tenendo conto del contesto specifico di ogni singolo caso.
Inoltre, anche quando si ottiene la deindicizzazione di un link dai risultati di ricerca, l’informazione originale rimane comunque accessibile sul web, ad esempio tramite gli archivi dei giornali online o i siti web che l’hanno pubblicata. Questo significa che il diritto all’oblio può essere facilmente aggirato, e che la “cancellazione” del passato digitale è spesso solo parziale. L’efficacia del diritto all’oblio dipende quindi dalla capacità di ottenere la rimozione dell’informazione anche dalla fonte originaria, il che può rivelarsi difficile o impossibile, soprattutto quando si tratta di informazioni pubblicate all’estero o da soggetti non facilmente identificabili.
Un’ulteriore sfida è rappresentata dalla diffusione dei social media e delle piattaforme di condivisione di contenuti. Questi strumenti amplificano enormemente la capacità di diffusione delle informazioni, rendendo sempre più difficile per gli individui esercitare un controllo effettivo sulla propria immagine pubblica. La pubblicazione, anche involontaria, di dati sensibili, la diffusione di notizie imprecise o tendenziose, la riproposizione di eventi negativi del passato possono compromettere seriamente la vita personale e professionale di un individuo, limitandone le opportunità e pregiudicandone la serenità.
Infine, l’applicazione del diritto all’oblio si scontra con i limiti territoriali delle leggi. La sentenza Google Spain ha stabilito che i motori di ricerca sono obbligati a deindicizzare i link dai risultati di ricerca visualizzati negli Stati membri dell’Unione Europea, ma non ha chiarito se questo obbligo si estende anche ai risultati di ricerca visualizzati al di fuori dell’UE. Questa questione è stata oggetto di un acceso dibattito, e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla questione, stabilendo che i motori di ricerca non sono tenuti a deindicizzare i risultati di ricerca a livello globale, ma solo a livello europeo.
Il diritto all’oblio oncologico: una tutela specifica
Un’evoluzione interessante nel panorama del diritto all’oblio è rappresentata dal riconoscimento del diritto all’oblio oncologico, volto a tutelare le persone guarite dal cancro dalla discriminazione e dallo stigma sociale. Questo diritto si fonda sulla consapevolezza che la pregressa malattia oncologica può rappresentare un ostacolo all’accesso a determinati servizi e opportunità, come l’assicurazione, il credito o l’adozione.
In Italia, a partire dal dicembre 2023, è stata introdotta una legge che riconosce il diritto all’oblio oncologico, consentendo alle persone guarite dal cancro di non subire discriminazioni a causa della loro pregressa malattia. Questa legge prevede, in particolare, che le persone guarite dal cancro non siano tenute a dichiarare la loro pregressa malattia per accedere a determinati servizi e opportunità, come l’assicurazione, il credito o l’adozione.
Per dare piena attuazione a questa legge, il Ministero della Salute ha emanato una serie di decreti attuativi, che definiscono le modalità di applicazione delle norme e individuano le patologie oncologiche per le quali il diritto all’oblio può essere esercitato anche prima del decorso di un determinato periodo di tempo dalla fine delle cure. Questi provvedimenti rappresentano un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone guarite dal cancro, contribuendo a superare lo stigma sociale e a promuovere la loro piena inclusione nella società. Si stima che circa una persona su 60 in Italia possa beneficiare di questo diritto.
La legge stabilisce che si è considerati guariti da un cancro quando sono trascorsi 10 anni dalla fine delle cure, ma introduce anche la possibilità di tempi più brevi, fino a un anno dalla conclusione delle cure, per alcuni tipi di tumore o situazioni. Ad esempio, per coloro che hanno ricevuto una diagnosi di malattia prima dei 21 anni, è sufficiente che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento oncologico.
Ciò implica che, grazie alla protezione offerta dal diritto all’oblio oncologico, gli individui che hanno superato il cancro possono accedere a finanziamenti come mutui o prestiti, sottoscrivere polizze assicurative, procedere con adozioni o partecipare a concorsi pubblici senza l’obbligo di fornire documentazione relativa alla loro storia clinica oncologica e senza subire di conseguenza discriminazioni o svantaggi. In precedenza, l’omissione di una diagnosi di cancro pregressa, quando richiesta da enti come banche e assicurazioni, era considerata una dichiarazione mendace e quindi perseguibile legalmente. Oggi, la normativa impone a tutte le aziende e gli enti di astenersi dal porre tale domanda, e conferisce a ogni cittadino la facoltà di non rispondere, qualora tale quesito venisse comunque formulato riguardo a una pregressa diagnosi di tumore.
Verso un futuro consapevole: equilibrio tra memoria e oblio
Il diritto all’oblio, pur rappresentando una conquista fondamentale per la tutela della dignità e della riservatezza degli individui nell’era digitale, non può essere considerato un diritto assoluto. La sua applicazione concreta richiede un costante bilanciamento con altri diritti e interessi meritevoli di tutela, quali la libertà di espressione, il diritto all’informazione e la memoria storica. Il futuro del diritto all’oblio dipenderà dalla capacità di trovare un punto di equilibrio tra questi interessi contrapposti, definendo regole chiare e precise che consentano di tutelare la privacy degli individui senza compromettere la libertà di informazione e la memoria collettiva. La sfida è quella di costruire una società digitale più consapevole e responsabile, in cui la memoria e l’oblio possano convivere in armonia.
Il tema del diritto all’oblio online ci porta inevitabilmente a riflettere su un concetto legale fondamentale: la responsabilità. Nel contesto digitale, la responsabilità per la diffusione di informazioni, vere o false che siano, è un tema complesso e in continua evoluzione. Chi è responsabile per un contenuto diffuso online? Il creatore del contenuto, il gestore della piattaforma che lo ospita, il motore di ricerca che lo indicizza? La risposta a queste domande non è sempre semplice, e dipende da una serie di fattori, come la natura del contenuto, il ruolo del soggetto coinvolto e la normativa applicabile.
Un concetto legale più avanzato, strettamente legato al diritto all’oblio, è quello di “data governance”. La data governance si riferisce all’insieme delle politiche, delle procedure e delle responsabilità che definiscono come i dati vengono gestiti all’interno di un’organizzazione o di una comunità. Una data governance efficace è essenziale per garantire che i dati siano accurati, completi, sicuri e utilizzati in modo etico e responsabile. Nel contesto del diritto all’oblio, una data governance efficace può contribuire a garantire che le richieste di cancellazione dei dati siano gestite in modo tempestivo e appropriato, nel rispetto dei diritti degli interessati e degli obblighi legali.
La riflessione sul diritto all’oblio ci invita a interrogarci sul nostro rapporto con il passato, sul valore della memoria e sulla necessità di poter voltare pagina. In un mondo in cui tutto viene registrato e archiviato, la possibilità di poter cancellare il nostro passato digitale assume un significato sempre più importante, non solo per proteggere la nostra privacy, ma anche per preservare la nostra libertà e la nostra dignità.