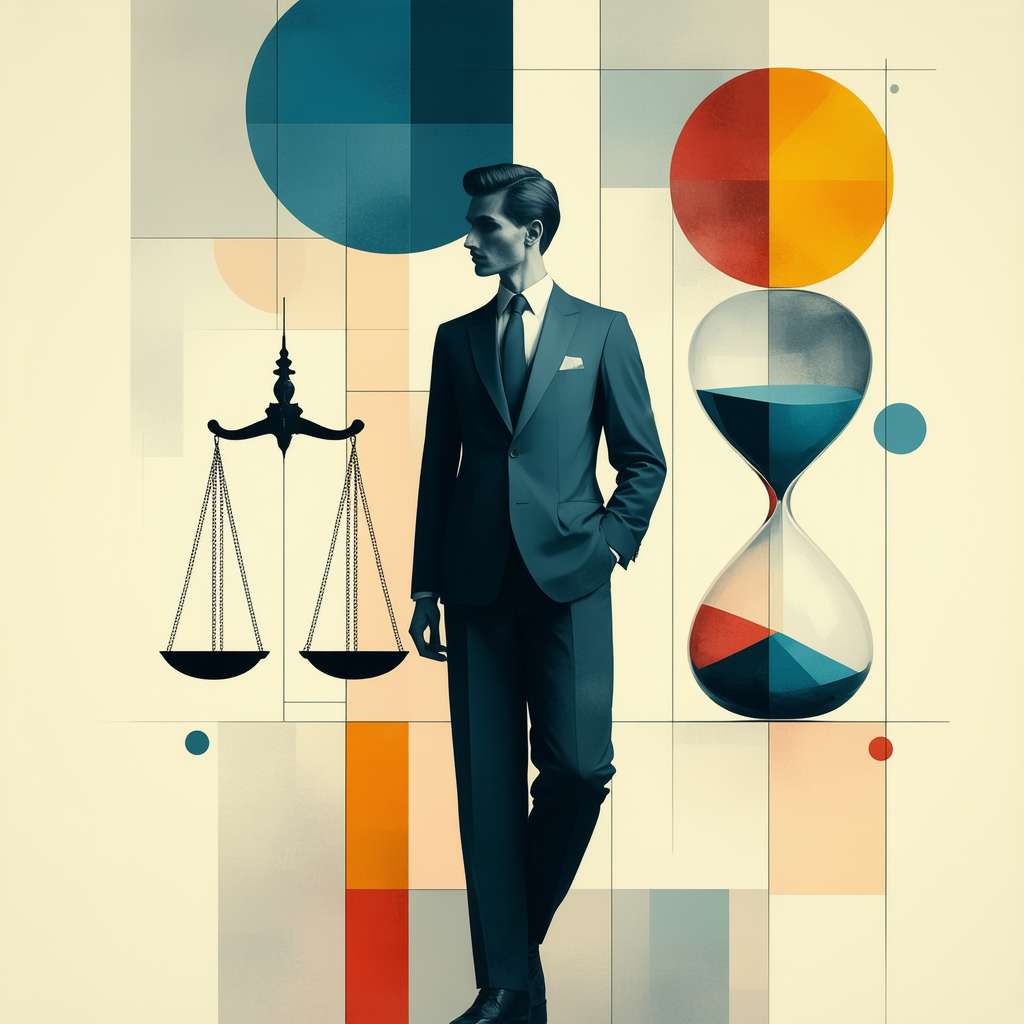E-Mail: [email protected]
- Cassazione esclude legami Dell'Utri-Berlusconi con Cosa Nostra, ma permangono indagini.
- GDPR art. 17: diritto alla cancellazione dati non necessari.
- Cassazione 6806/2023: no cancellazione automatica notizie senza richiesta.
Il caso Dell’Utri e la gogna mediatico-giudiziaria
Il caso di Marcello Dell’Utri, figura poliedrica della politica e dell’imprenditoria italiana, si ripropone oggi, 23 ottobre 2025, come un paradigma delle sfide poste dall’era digitale al diritto all’oblio e alla tutela della reputazione. La vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto per anni, culminata in accuse di concorso esterno in associazione mafiosa, solleva interrogativi cruciali sul bilanciamento tra il diritto all’informazione e il diritto a non essere perseguitati da un passato controverso, soprattutto quando questo passato continua a riverberarsi nell’eco amplificata del web.
Nonostante la recente pronuncia della Cassazione che ha escluso legami tra Dell’Utri, Silvio Berlusconi e Cosa Nostra, rigettando la richiesta di sorveglianza speciale e confisca dei beni, permangono ombre e nuove indagini, come quella relativa al concorso nella strage di via D’Amelio, per quanto destinata all’archiviazione. Questa situazione paradossale evidenzia una persistente “gogna mediatico-giudiziaria”, un fenomeno in cui l’eco delle accuse passate continua a gravare su un individuo, anche quando la giustizia ha fatto il suo corso o si appresta a farlo. È una condizione di sospensione perpetua, dove la vita di una persona rimane immersa nel “fango mediatico-giudiziario”, come ha efficacemente descritto un giornalista esperto di cronaca giudiziaria.
La questione si fa ancora più complessa se si considera l’impatto della prescrizione. Se un reato è prescritto, l’individuo non è più perseguibile legalmente, ma la sua reputazione può rimanere compromessa dalla persistenza di informazioni online che ricordano quel reato. In questi casi, il diritto all’oblio può essere invocato per “deindicizzare” queste informazioni dai motori di ricerca, rendendole meno accessibili al pubblico. Tuttavia, la deindicizzazione non cancella il contenuto, ma lo rende meno visibile, sollevando interrogativi sul ruolo della memoria collettiva e sul diritto di un individuo a essere dimenticato.
Il diritto all’oblio, come sancito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), offre una potenziale via d’uscita da questa spirale. L’articolo 17 del GDPR prevede il diritto alla cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti, quando l’interessato revoca il consenso o quando i dati sono stati trattati illecitamente. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, come il diritto alla libertà di espressione e di informazione.
La giurisprudenza italiana, in linea con quella europea, ha cercato di definire i confini del diritto all’oblio, stabilendo che le testate giornalistiche non sono tenute a cancellare o aggiornare automaticamente le notizie, a meno che non ricevano una specifica richiesta dall’interessato. La sentenza n. 6806 del 7 marzo 2023 della Cassazione ha chiarito che il gestore di un sito web non è obbligato a cancellare, deindicizzare o aggiornare un articolo di stampa legittimamente pubblicato, anche se relativo a fatti risalenti nel tempo, in assenza di una richiesta dell’interessato. Questa decisione sottolinea l’importanza di bilanciare il diritto all’informazione con il diritto alla protezione della reputazione, un equilibrio delicato e fondamentale per una società democratica.
Il caso Dell’Utri, quindi, si configura come un banco di prova per il sistema giuridico e per la società civile, chiamati a confrontarsi con le sfide poste dall’era digitale alla tutela dei diritti fondamentali. Si tratta di una riflessione necessaria per evitare che la memoria del web si trasformi in una gogna permanente, cancellando la possibilità di redenzione e reinserimento sociale.
- È fondamentale tutelare la dignità umana nell'era digitale…...
- La gogna mediatico-giudiziaria è una forma di persecuzione… 😠...
- Il diritto all'oblio non è un favore, ma una necessità… 🤔...
Il diritto all’oblio: un diritto in evoluzione
Il diritto all’oblio non è un concetto statico, ma un diritto in continua evoluzione, plasmato dalle trasformazioni sociali e tecnologiche. La sua genesi affonda le radici nel diritto alla riservatezza e all’identità personale, riconosciuti e tutelati dall’articolo 2 della Costituzione italiana. Come ha sottolineato un autorevole giurista, il diritto all’oblio è una specificazione del diritto all’identità personale, inteso come il diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, di notizie pur legittimamente diffuse in origine, ma non più giustificate da nuove ragioni di attualità.
La rapida evoluzione dei mezzi di comunicazione, unita a una crescente attenzione per la vita privata e pubblica degli individui, ha reso necessario focalizzare l’attenzione sul diritto dei singoli al riserbo e all’oblio. Questo diritto si contrappone al diritto all’informazione, garantito dall’articolo 21 della Costituzione, e richiede un delicato bilanciamento tra interessi contrapposti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore, della reputazione o della riservatezza di terzi è lecita solo se sussistono tre condizioni: la verità dei fatti esposti, l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza dell’esposizione.
Tuttavia, l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia non giustifica automaticamente la pubblicazione o la diffusione dell’immagine delle persone coinvolte. In questi casi, è necessario accertare uno specifico e autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda, oppure ottenere il consenso delle persone ritratte, o ancora verificare l’esistenza di altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento.
Il diritto all’oblio si inserisce in questa dicotomia, rappresentando una delle forme che può assumere il diritto alla riservatezza. Si tratta del diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, di notizie pur legittimamente diffuse in origine, ma non più giustificate da nuove ragioni di attualità. La salvaguardia di tale diritto si scontra, nella pratica, con la possibilità che in rete permangano notizie, anche datate, spesso superate da eventi successivi e, pertanto, non più attuali.
La differenza tra una notizia pubblicata sul web e una notizia pubblicata su un supporto cartaceo risiede nella facilità con cui si accede al contenuto. I motori di ricerca, attraverso i loro indici, consentono di individuare rapidamente informazioni di vario genere relative a una persona, anche molto risalenti nel tempo. Per questa ragione, assicurare il diritto all’oblio nell’era digitale è estremamente complesso. In queste situazioni, la tutela del diritto all’oblio si attua mediante la deindicizzazione, che non comporta l’eliminazione del contenuto, ma ne impedisce l’accesso diretto tramite i motori di ricerca esterni all’archivio che lo ospita.
La Suprema Corte ha stabilito, in materia di protezione dei dati personali, che l’eliminazione delle copie cache di un’informazione rintracciabile tramite un motore di ricerca non consegue automaticamente alla presenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome del soggetto interessato. È invece necessaria una valutazione comparata tra il diritto all’oblio della persona e il diritto alla divulgazione e all’acquisizione delle informazioni relative al fatto, anche attraverso termini di ricerca diversi dal nome della persona stessa.
Di conseguenza, anche prima dell’entrata in vigore del GDPR, qualora un articolo di interesse generale, pubblicato sul web, risulti lesivo dei diritti di un individuo che non sia un personaggio pubblico, è possibile ordinare la deindicizzazione dell’articolo dal motore di ricerca. Questo serve a prevenire che un accesso facilitato e prolungato nel tempo ai dati personali di tale soggetto possa pregiudicare il suo diritto a non essere costantemente associato a una “biografia telematica” difforme da quella reale e composta da notizie ormai superate.
In sintesi, il diritto all’oblio non implica una cancellazione totale della notizia, della cui conservazione può persistere un interesse.
Sentenze significative e il ruolo della Corte di giustizia europea
La giurisprudenza nazionale ed europea ha contribuito a definire i contorni del diritto all’oblio, attraverso sentenze che hanno affrontato questioni complesse e sollevato interrogativi cruciali sul bilanciamento tra diritti fondamentali. Tra le sentenze più significative, spicca la pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea (CGUE) dell’8 dicembre 2022 nella causa C-460/20. In questa sentenza, la CGUE ha dichiarato che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità.
In quella decisione, la CGUE ha anche chiarito che il GDPR esclude esplicitamente la possibilità di cancellazione quando il trattamento dei dati è necessario per esercitare un diritto correlato, specificamente la libertà di espressione.
Contemporaneamente, l’articolo 17 del GDPR consente all’interessato di richiedere al fornitore di un motore di ricerca online la rimozione di uno o più link a pagine web dall’elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca effettuata basandosi sul suo nome.
Con la sentenza del 24 settembre 2019, C-507/2017 (relativa al caso CNIL), il tribunale europeo ha stabilito che l’azione di catalogare e conservare in modo automatico i dati messi a disposizione del pubblico online rientra nella sfera del trattamento dei dati personali, e di questo il gestore del motore di ricerca è ritenuto responsabile.
La Corte ha ulteriormente specificato che l’azione per la deindicizzazione deve essere intrapresa nei confronti del proprietario del motore di ricerca, in quanto detentore e gestore dei dati personali, il quale ha la responsabilità, al verificarsi delle condizioni previste dalle normative del regolamento e, precedentemente, della direttiva, di rimuovere e sopprimere dall’elenco dei risultati che emergono da una ricerca effettuata inserendo il nome di una persona, i collegamenti che puntano a siti web creati da terzi e contenenti informazioni concernenti l’interessato, anche se di per sé leciti. Questo vale, per esempio, nei casi in cui la notizia non sia più attuale o rilevante, a meno che, per motivi particolari come il ruolo pubblico svolto dall’individuo, non prevalga un interesse pubblico superiore che giustifichi l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali.
Una potenziale fragilità della tutela offerta dal GDPR riguarda la sua estensione geografica. Il Regolamento si applica se l’organizzazione ha la sua sede operativa all’interno dell’Unione Europea, oppure se, pur non avendo sede nell’UE, offre beni o servizi (anche gratuitamente) a cittadini europei, o ancora se monitora il comportamento di residenti nell’Unione, a condizione che tale comportamento si svolga nel territorio comunitario.
Questo crea un problema per le notizie indicizzate su motori di ricerca che presentano diverse versioni, una per l’Europa e altre per regioni extraeuropee.
Qualora l’ordine di deindicizzazione venisse applicato solo alla versione europea, la protezione del diritto all’oblio risulterebbe insufficiente. Attraverso le altre versioni dello stesso motore di ricerca, sarebbe infatti possibile accedere agevolmente alla biografia completa della persona, includendo anche le informazioni non più rilevanti o superate da eventi successivi.
La giurisprudenza nazionale garantisce la massima protezione possibile, stabilendo che, quando sono in gioco diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, il giudice italiano ha la facoltà di emettere un ordine di deindicizzazione con efficacia extraterritoriale (anche al di fuori dell’UE).
La Cassazione ha stabilito che, “In materia di trattamento dei dati personali, la salvaguardia del “diritto all’oblio” permette, in armonia con la legislazione dell’Unione Europea, alle autorità italiane, vale a dire il Garante per la protezione dei dati personali e l’autorità giudiziaria, di imporre al gestore di un motore di ricerca di eseguire una rimozione dai risultati di ricerca su tutte le varianti, incluse quelle esterne ai confini europei, di quel dato motore, tenendo in equilibrio il diritto dell’interessato alla tutela della sua sfera privata e alla protezione delle sue informazioni personali, e il diritto alla libertà di informazione, da realizzarsi in accordo con i canoni di protezione dell’ordinamento italiano”.
Tale decisione è stata presa pur essendo consapevoli che, in Paesi dove, in teoria, potrebbe esserci uno standard di tutela dei diritti della personalità meno stringente a fronte di una maggiore libertà di informazione, ciò potrebbe tradursi nel mancato riconoscimento della decisione italiana o in difficoltà nella sua esecuzione. Tuttavia, come evidenziato nella sentenza, si tratta di obiezioni di natura puramente pratica.

Diritto di ricordare vs diritto di essere dimenticati: un dilemma etico
Il caso Dell’Utri, al di là delle specifiche vicende giudiziarie, pone una questione etica fondamentale: la società ha il diritto di ricordare, anche quando il ricordo può ledere la reputazione di un individuo, o un individuo ha il diritto di essere dimenticato, soprattutto quando ha espiato le sue colpe o quando i reati contestati sono prescritti? Questo dilemma si acuisce nell’era digitale, dove ogni informazione è potenzialmente eterna e dove la “memoria del web” può trasformarsi in una gogna permanente.
La risposta a questa domanda non è semplice e richiede una riflessione approfondita sui valori che guidano la nostra società. Da un lato, la memoria storica è fondamentale per imparare dagli errori del passato e per evitare di ripeterli. La conoscenza dei fatti, anche quelli più controversi, è essenziale per formare una coscienza civica consapevole e per garantire la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni. Dall’altro lato, il diritto alla dignità e alla reputazione è un diritto fondamentale che deve essere tutelato, soprattutto quando si tratta di persone che hanno pagato il loro debito con la giustizia o che sono state assolte dalle accuse.
Il diritto all’oblio non è un diritto a riscrivere la storia, ma un diritto a non essere perseguitati dal passato quando questo passato non ha più rilevanza giuridica o sociale. È un diritto a una “seconda possibilità”, a un nuovo inizio. Come ha affermato un esperto di diritto all’oblio, il diritto all’oblio è un diritto a non essere perseguitati dal passato quando questo passato non ha più rilevanza giuridica o sociale. È un diritto a una ‘seconda possibilità’, a un nuovo inizio.
Tuttavia, il diritto all’oblio non deve essere interpretato come un diritto a cancellare la memoria collettiva. La società ha bisogno di ricordare, anche gli eventi più dolorosi, per costruire un futuro migliore. Il compito del giornalismo è informare, ma i giornalisti devono essere consapevoli dell’impatto che le loro parole possono avere sulla vita delle persone, soprattutto quando si tratta di vicende passate. È necessario chiedersi se la ripubblicazione di una notizia vecchia risponde a un reale interesse pubblico o se serve solo a alimentare il voyeurismo.
Trovare un equilibrio tra il diritto alla conoscenza e il diritto alla dignità è una sfida complessa, ma necessaria. La deindicizzazione, come strumento, offre una soluzione parziale, permettendo di limitare la diffusione di informazioni obsolete o lesive, senza però cancellare la memoria storica. Il vero nodo da sciogliere è etico: quanto siamo disposti a perdonare e a dimenticare, e quanto invece riteniamo necessario mantenere viva la memoria del passato?
Verso un nuovo umanesimo digitale: bilanciare memoria e oblio
Il caso Dell’Utri ci spinge a riflettere su un tema più ampio e cruciale per il futuro delle nostre società: la necessità di un nuovo umanesimo digitale, capace di bilanciare la potenza della tecnologia con i valori fondamentali della dignità umana, della libertà e della giustizia. In un mondo in cui l’informazione è onnipresente e la memoria digitale sembra infinita, è fondamentale sviluppare una cultura della responsabilità e della consapevolezza, che tenga conto dell’impatto che le nostre azioni online possono avere sulla vita delle persone.
Il diritto all’oblio rappresenta uno strumento importante per proteggere la reputazione e la dignità degli individui nell’era digitale, ma non è una panacea. È necessario un approccio più ampio, che coinvolga tutti gli attori della società: i legislatori, i giudici, i giornalisti, gli operatori del web e i cittadini. È necessario promuovere una cultura della responsabilità digitale, che incoraggi a condividere informazioni in modo consapevole e rispettoso, evitando di alimentare la gogna mediatica e di perpetuare il ricordo di eventi che non hanno più rilevanza giuridica o sociale.
È necessario investire nell’educazione civica digitale, per formare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri online. È necessario promuovere un giornalismo responsabile, che sappia bilanciare il diritto all’informazione con il diritto alla protezione della reputazione. È necessario che gli operatori del web adottino politiche trasparenti e rispettose dei diritti degli utenti, garantendo la possibilità di esercitare il diritto all’oblio in modo efficace e tempestivo.
Il futuro del diritto all’oblio dipenderà dalla nostra capacità di sviluppare un nuovo umanesimo digitale, capace di coniugare la potenza della tecnologia con i valori fondamentali della nostra civiltà. Solo così potremo evitare che la memoria del web si trasformi in una gogna permanente e garantire a tutti il diritto di essere dimenticati, quando il passato non ha più ragione di perseguitarci.
Amici, riflettiamo un attimo. Avete mai sentito parlare di “presunzione di innocenza“? È un principio cardine del nostro sistema legale: tutti sono innocenti fino a prova contraria. Applicato al caso Dell’Utri, e a molti altri, ci ricorda che il diritto all’oblio non è un favore, ma una necessità per non trasformare un’indagine o un processo in una condanna perpetua. Approfondendo, scopriamo che il “bilanciamento degli interessi” è una tecnica giuridica sofisticata, dove si soppesano diritti contrapposti (come informazione vs. privacy) per trovare la soluzione più giusta. Ecco, il caso Dell’Utri è un esempio lampante di come questo bilanciamento sia complesso e delicato, soprattutto nell’era digitale. Pensiamoci un po’: come possiamo garantire che la sete di conoscenza non si trasformi in una spietata macchina del fango?