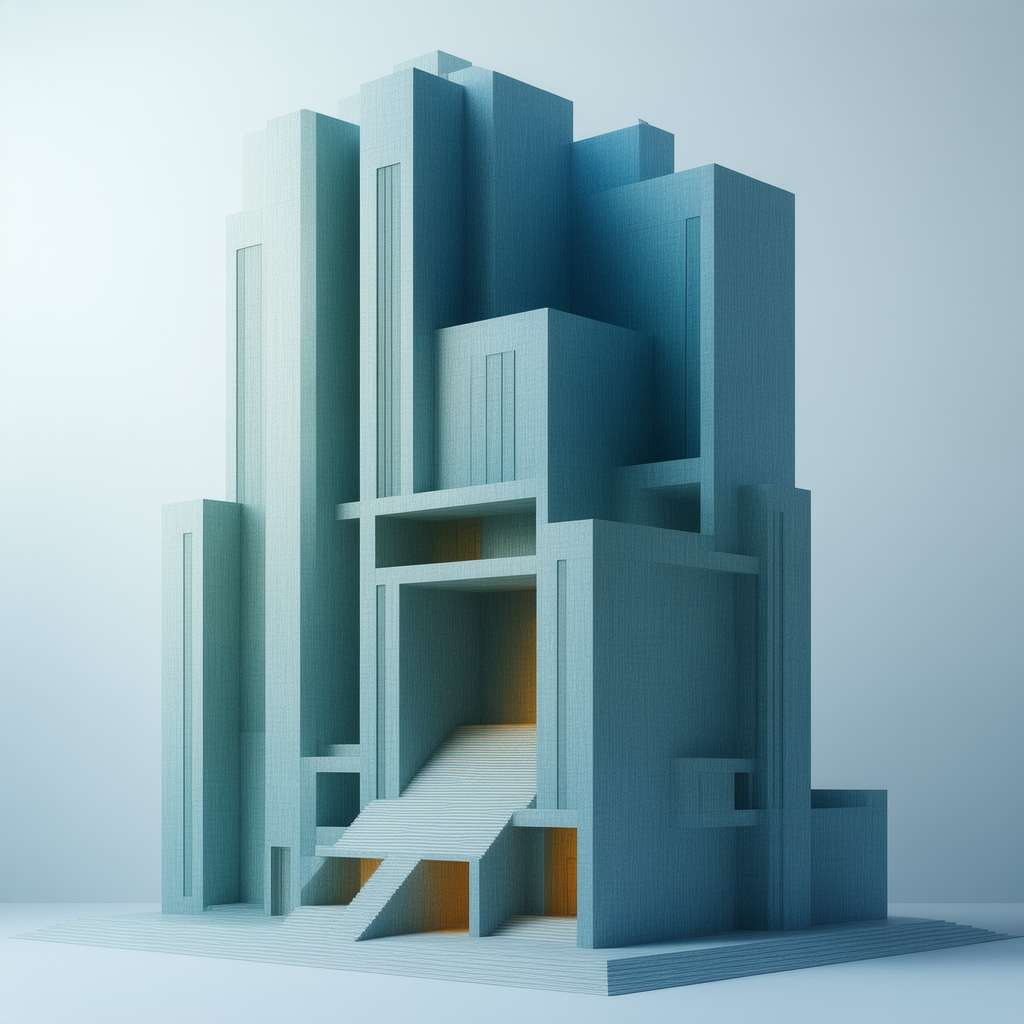E-Mail: [email protected]
- Nel 2009 l'Italia ha introdotto l'articolo 612-bis sul reato di stalking.
- Il 21,5% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito stalking.
- La legge 69/2019 (Codice Rosso) ha inasprito le sanzioni per stalking.
Il panorama legale e sociale si confronta oggi con una realtà inquietante: lo stalking ha trasceso i confini fisici per radicarsi nel cyberspazio. A fare da monito, la recente sentenza di condanna emessa a Vibo Valentia per un caso di stalking perpetrato attraverso molestie telefoniche e messaggi. Questo episodio funge da catalizzatore per esaminare la complessa evoluzione del reato di stalking nell’era digitale, un’era in cui le nuove tecnologie amplificano le possibilità di persecuzione, rendendo ardua la raccolta di prove concrete e la protezione delle vittime.
Dalla cornetta al click: Lo stalking si fa digitale
L’articolo 612-bis del codice penale, introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano nel 2009, definisce il reato di stalking come una serie di condotte reiterate di minaccia o molestia che cagionano un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, ingenerando un fondato timore per la propria incolumità o alterandone le abitudini di vita. Questa norma, inizialmente concepita per punire le forme tradizionali di persecuzione, ha subito un’importante evoluzione per includere anche le condotte poste in essere attraverso strumenti informatici o telematici, delineando così la figura del cyberstalking.
Il cyberstalking, tuttavia, non è una mera trasposizione del reato di stalking nel mondo digitale. Esso presenta caratteristiche peculiari che lo rendono più insidioso e difficile da contrastare. Le nuove tecnologie offrono agli stalker un’ampia gamma di strumenti per perseguitare le proprie vittime: social media, applicazioni di messaggistica, email, forum online. L’anonimato garantito da internet, la possibilità di creare profili falsi e la velocità di diffusione delle informazioni rendono più facile per i persecutori agire indisturbati, mentre per le vittime diventa più difficile difendersi e raccogliere prove concrete delle molestie subite.
La definizione dei concetti di “molestia” e “minaccia” online è un’ulteriore sfida per il diritto penale. Cosa si intende per molestia in un contesto virtuale dove la comunicazione è spesso mediata da schermi e tastiere? Come distinguere una critica legittima da un’aggressione verbale? Come valutare la gravità di una minaccia online quando non è accompagnata da una presenza fisica? Queste sono solo alcune delle domande a cui la giurisprudenza è chiamata a rispondere per adattare la legge alla realtà del cyberstalking.
Le statistiche rivelano la gravità del fenomeno. Secondo le stime, il 21,5% delle donne residenti in Italia, nella fascia d’età tra i 16 e i 70 anni, ha affrontato comportamenti persecutori da parte di un ex partner nel corso della propria vita. Un dato allarmante che sottolinea la necessità di una maggiore attenzione e di strumenti di tutela più efficaci.
La possibilità di nascondersi dietro l’anonimato o di fabbricare identità fittizie accresce il senso di vulnerabilità della persona bersagliata. La natura intrinseca del digitale assicura una diffusione e una persistenza illimitate delle azioni offensive o intimidatorie. I contenuti veicolati non solo hanno il potenziale di diventare virali in un batter d’occhio, ma lasciano una traccia digitale permanente che trascende i confini spaziali e temporali della persecuzione fisica.
- Articolo utilissimo, finalmente qualcuno che spiega come difendersi... 👍...
- Cyberstalking, un problema sottovalutato... 😠...
- Ma se lo stalker fossimo noi?... 🤔...
Giurisprudenza e cyberstalking: Un equilibrio delicato
La giurisprudenza italiana ha affrontato diverse volte il tema del cyberstalking, cercando di applicare le norme esistenti alle nuove forme di persecuzione online. La Corte di Cassazione ha affermato che messaggi minatori o diffamatori inviati tramite social network possono integrare il reato di stalking se idonei a provocare un grave stato di ansia e di paura nella vittima. Inoltre, la pubblicazione di contenuti offensivi online costituisce un danno di per sé, a prescindere dalla presa visione degli stessi da parte della vittima.
Un caso emblematico è quello di un uomo che, dopo la separazione dalla compagna, aveva creato falsi profili sui social network con il nome della ex, pubblicando annunci a sfondo sessuale. La Corte di Cassazione ha condannato l’uomo per stalking, ritenendo che la sua condotta avesse causato alla vittima un grave stato di ansia e di paura. Va considerato, inoltre, che la tutela si estende anche ai familiari stretti. Il reato può configurarsi anche attraverso condotte non direttamente indirizzate alla vittima, ma che la coinvolgono indirettamente, come l’invio di messaggi minacciosi al figlio della coppia.
La prova digitale nel cyberstalking rappresenta una sfida cruciale. Affinché la prova sia pienamente utilizzabile in sede processuale, è indispensabile garantire i principi di integrità e autenticità del dato. Semplici screenshot o stampe cartacee hanno un valore probatorio limitato se contestati in dibattimento. Si rende indispensabile un’acquisizione tecnica forense per assicurare l’originalità del dato informatico, includendo metadati fondamentali quali l’orario esatto di trasmissione, il tipo di dispositivo utilizzato e l’identificatore univoco del contenuto.
Tuttavia, la giurisprudenza si trova a dover bilanciare la tutela delle vittime con la libertà di espressione e il diritto alla privacy. Non è sempre facile stabilire quando un comportamento online costituisce una molestia o una minaccia, soprattutto quando si tratta di espressioni ambigue o ironiche. Inoltre, la giurisprudenza deve tenere conto del contesto in cui si verificano le condotte persecutorie, valutando se si tratta di un litigio occasionale o di una vera e propria campagna di stalking. La legge 69/2019 (cosiddetto Codice Rosso) ha inasprito le sanzioni per il reato di stalking, ma la sfida di applicare la norma al cyberstalking rimane aperta.

Il parere degli esperti: Avvocati e psicologi a confronto
Per comprendere appieno l’impatto psicologico del cyberstalking e individuare le strategie legali più efficaci per proteggere le vittime, è fondamentale ascoltare il parere degli esperti. Avvocati specializzati in diritto penale e psicologi forensi sottolineano come il cyberstalking possa causare nelle vittime un grave stato di ansia, paura e depressione, compromettendone la vita personale, sociale e professionale. L’avvocato penalista Paolo Galdieri afferma che “il cyberstalking amplifica la violenza, garantendo anonimato al persecutore e accessibilità illimitata alle condotte offensive”.
L’esperto sottolinea come l’aggressione digitale non rimanga confinata nel virtuale, ma “trapela nel mondo fisico della vittima”, colpendo soprattutto le donne con forme di sessismo, body shaming e minacce di violenza sessuale. Galdieri evidenzia inoltre una lacuna nell’approccio italiano al cyberstalking, che punisce principalmente l’uso dello strumento informatico, senza considerare il danno reputazionale permanente causato alla vittima. Per questo, è fondamentale standardizzare le metodologie di acquisizione della prova digitale e investire in educazione e sensibilizzazione per combattere la misoginia, che rappresenta la radice del cyberstalking.
Gli psicologi forensi, dal canto loro, evidenziano come il cyberstalking possa portare le vittime a sviluppare disturbi d’ansia, attacchi di panico, depressione, insonnia e disturbi alimentari. In alcuni casi, le vittime possono arrivare a isolarsi socialmente, a cambiare lavoro o a trasferirsi in un’altra città per sfuggire al persecutore. È quindi fondamentale che le vittime di cyberstalking ricevano un sostegno psicologico adeguato, per superare il trauma subito e riprendere il controllo della propria vita. Il danno psicologico è amplificato dalla natura pervasiva e persistente delle molestie online, che possono raggiungere la vittima in qualsiasi momento e luogo.
La protezione efficace della vittima è subordinata all’adozione di standard investigativi tecnici di alto livello. La carenza di un protocollo investigativo forense omogeneo genera un notevole rischio di dispute probatorie sull’affidabilità dell’acquisizione, costringendo la vittima a dover convalidare la veridicità delle prove e aggravando il danno psicologico e il suo senso di impotenza.
Ben oltre la mera esasperazione tecnologica degli atti persecutori, il cyberstalking si rivela una chiara concretizzazione della violenza di genere. In questa forma di sopruso, l’infrastruttura digitale viene sfruttata per potenziare sia l’impatto dannoso sulle vittime, sia la sensazione di dominio e controllo da parte dell’aggressore.
Responsabilità dei provider: Un nodo cruciale
Un altro tema centrale nella lotta al cyberstalking è quello della responsabilità dei provider di servizi internet. La legge italiana, in linea con la direttiva europea sul commercio elettronico, prevede che i provider non siano responsabili dei contenuti pubblicati dagli utenti, a meno che non siano a conoscenza della loro illiceità e non intervengano per rimuoverli. Questa norma, concepita per tutelare la libertà di espressione e favorire lo sviluppo del commercio online, rischia però di creare una zona grigia in cui i provider possono sottrarsi alle proprie responsabilità, lasciando le vittime di cyberstalking senza protezione.
La giurisprudenza è in continua evoluzione, e si discute se i provider debbano avere un ruolo più attivo nella prevenzione e repressione del cyberstalking. Alcuni sostengono che i provider dovrebbero essere obbligati a monitorare i contenuti pubblicati dagli utenti e a rimuovere quelli che violano la legge, mentre altri ritengono che un obbligo di sorveglianza preventiva lederebbe la libertà di espressione e ostacolerebbe l’innovazione tecnologica. La Commissione europea ha promosso un approccio basato sulla cooperazione tra autorità e piattaforme digitali, invitando i provider a dotarsi di strumenti efficaci per la segnalazione e la rimozione dei contenuti illeciti.
L’articolo di Agenda Digitale offre una panoramica sulla responsabilità dei provider per i contenuti illeciti pubblicati dagli utenti. I provider non sono responsabili dei contenuti pubblicati dagli utenti, a meno che non siano a conoscenza della loro illiceità e non intervengano per rimuoverli. La direttiva europea sul commercio elettronico (2000/31/CE) prevede diverse categorie di intermediari digitali, con diversi regimi di esenzione da responsabilità. Le autorità possono esigere dai provider di impedire o porre fine alle violazioni commesse attraverso i contenuti degli utenti. I provider non sono soggetti a un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti.
In questo contesto, è fondamentale che i provider collaborino attivamente con le autorità per identificare e perseguire i cyberstalker, fornendo informazioni utili alle indagini e rimuovendo tempestivamente i contenuti illeciti. Inoltre, i provider dovrebbero adottare misure per proteggere la privacy degli utenti e prevenire l’abuso dei propri servizi, ad esempio implementando sistemi di segnalazione anonima e offrendo strumenti per bloccare i contatti indesiderati.
Verso una tutela più efficace: Un approccio integrato
La lotta al cyberstalking richiede un approccio integrato che coinvolga tutti gli attori della società: istituzioni, forze dell’ordine, magistratura, avvocati, psicologi, provider di servizi internet e cittadini. È necessario un quadro normativo chiaro e aggiornato, che definisca in modo preciso i comportamenti costituenti cyberstalking e preveda sanzioni adeguate per i responsabili. La giurisprudenza deve essere attenta all’evoluzione tecnologica e pronta a interpretare le norme esistenti alla luce delle nuove sfide poste dal cyberspazio.
È fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza del problema del cyberstalking, sensibilizzando l’opinione pubblica sui rischi e sulle conseguenze di questo reato. Le vittime devono essere informate sui propri diritti e sugli strumenti di tutela a loro disposizione, e devono ricevere un sostegno psicologico adeguato per superare il trauma subito. I provider di servizi internet devono collaborare attivamente con le autorità per prevenire e reprimere il cyberstalking, adottando misure per proteggere la privacy degli utenti e rimuovere tempestivamente i contenuti illeciti.
Alla base del cyberstalking vi è l’odio verso le donne.
Ogni iniziativa legislativa deve essere sostenuta da un cospicuo investimento in percorsi educativi e campagne di sensibilizzazione, a partire dalle scuole, per disinnescare alla radice il senso di prevaricazione e controllo che nutre l’aggressione di genere. Solo combinando una protezione penale mirata con standard investigativi impeccabili e una profonda trasformazione culturale contro il sessismo, si potrà erigere una difesa robusta e duratura contro questa insidiosa forma di sopruso.
Il recepimento della Direttiva UE 2024/1385, che imporrà di criminalizzare lo stalking online e le molestie digitali come reati autonomi, sarà cruciale per allineare la nostra legislazione. Ma da sola non basta. È di fondamentale importanza uniformare le procedure di acquisizione delle prove digitali (come la digital forensic copy) sin dalle prime fasi della denuncia, riducendo così le controversie probatorie che costringono la vittima a rivivere il trauma per convalidare l’autenticità dei dati.
Oltre la norma: Riflessioni sull’ossessione digitale
Amici, addentrandoci in queste pieghe del diritto, ci imbattiamo in una verità scomoda: la legge, per quanto necessaria, è solo un argine. Il vero cambiamento nasce dalla consapevolezza. Il cyberstalking, come abbiamo visto, è una deriva dell’ossessione, un’ombra che si proietta nel digitale. Ma l’ossessione, in fondo, è una distorsione del desiderio, una pretesa di possesso che nega l’alterità.
Qui, una nozione legale basilare ci viene in soccorso: il diritto alla riservatezza. Ciascuno di noi ha il diritto di proteggere la propria sfera privata, di non subire intrusioni indesiderate. Ma questo diritto, per essere davvero efficace, deve essere accompagnato da una consapevolezza interiore. Dobbiamo imparare a proteggere i nostri confini, a dire “no” alle pretese altrui, a coltivare un sano rispetto per noi stessi e per gli altri.
E qui, una nozione legale avanzata ci sfida: il principio di autodeterminazione informativa. Questo principio, che affonda le radici nel diritto alla protezione dei dati personali, ci dice che ciascuno di noi ha il diritto di controllare l’uso che viene fatto delle proprie informazioni. Ma questo diritto, per essere davvero esercitato, richiede una partecipazione attiva. Dobbiamo essere consapevoli di quali dati condividiamo online, di come vengono utilizzati dalle piattaforme digitali, di quali sono i rischi per la nostra privacy.
Il cyberstalking, allora, non è solo un problema legale, ma un problema culturale. Un problema che ci chiama in causa come individui, come cittadini, come esseri umani. Dobbiamo interrogarci sulle nostre relazioni, sui nostri desideri, sulle nostre ossessioni. Dobbiamo imparare a riconoscere i segnali di pericolo, a chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno, a costruire una cultura del rispetto e della responsabilità nel mondo digitale.