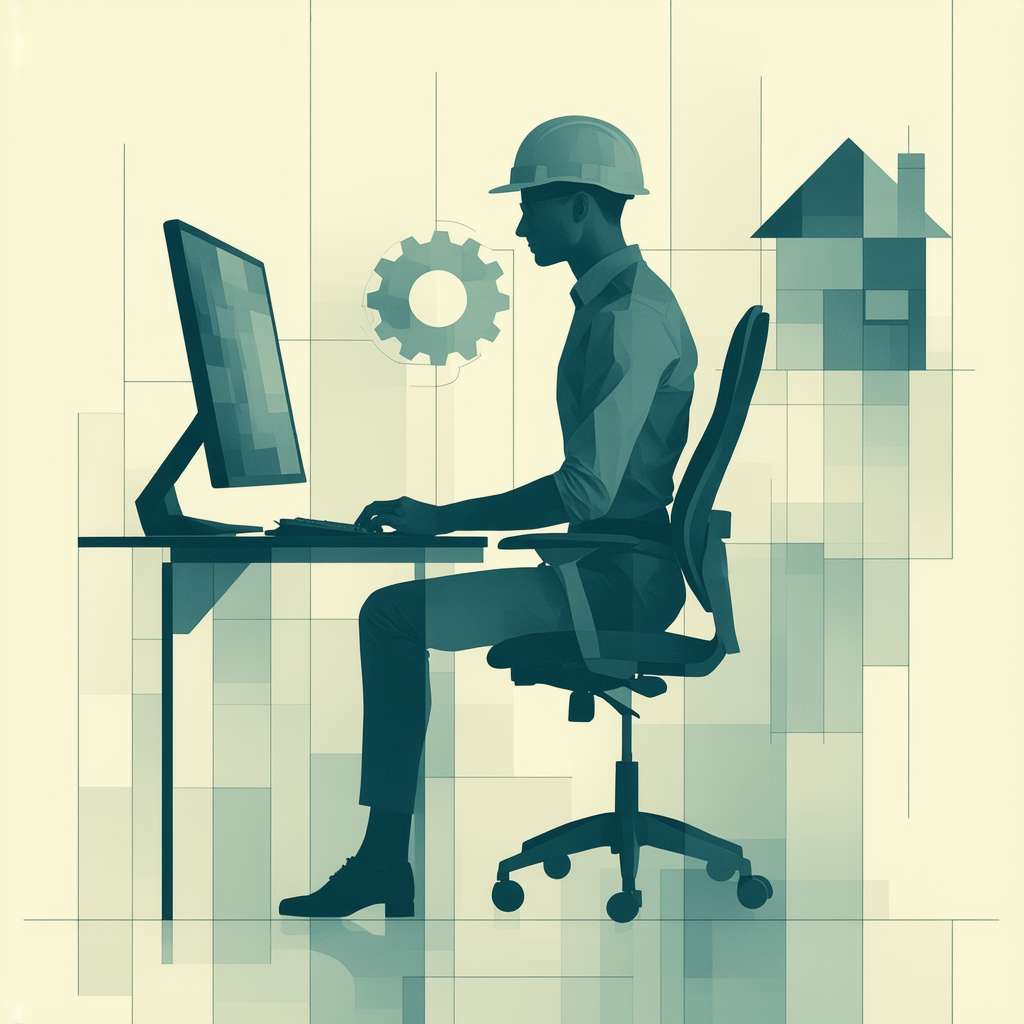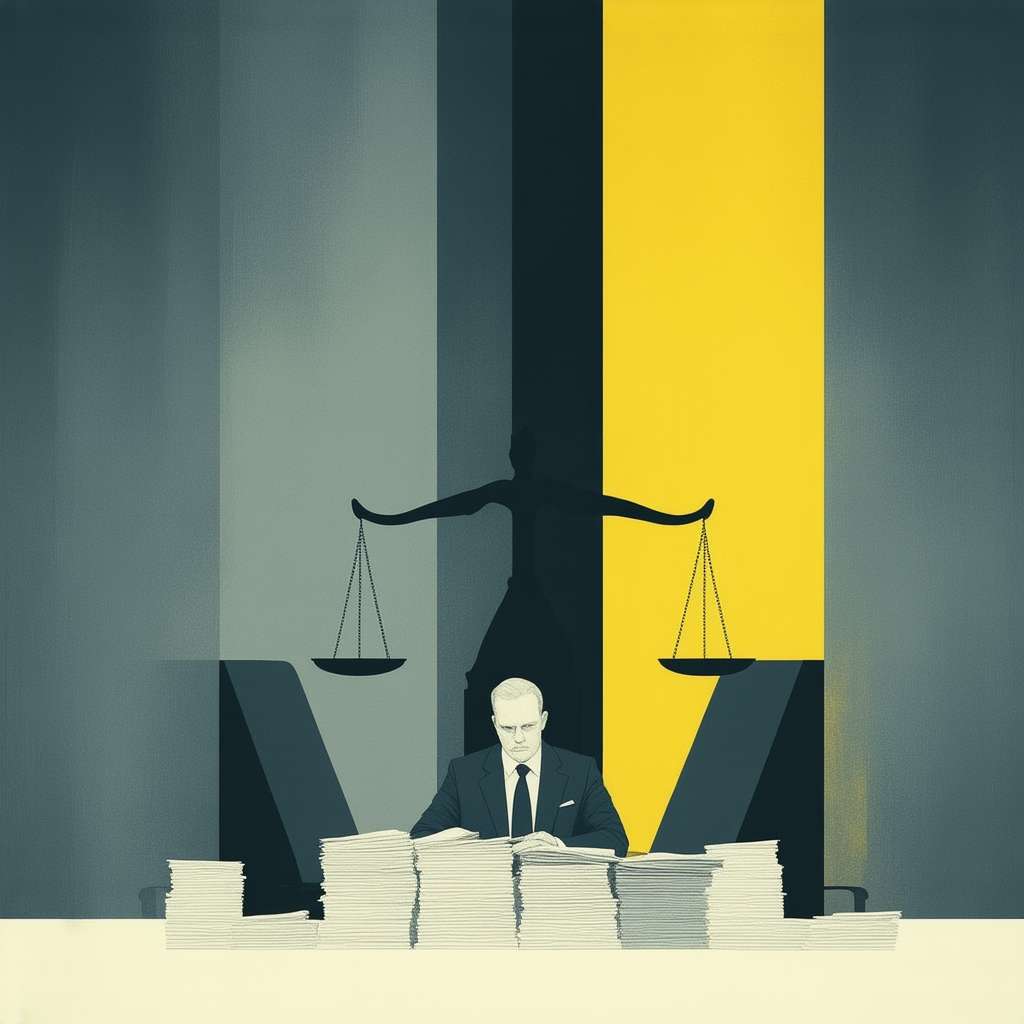E-Mail: [email protected]
- La Cassazione ribalta il licenziamento: tutelato il whistleblowing.
- Articolo 21 Costituzione: diritto di critica con limiti.
- Decreto legislativo n. 24 del 2023: tutela del whistleblower.
Una riunione infiammata durante la pandemia
Nel panorama lavorativo italiano, la sentenza n. 10864/2025 della Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, del 24 aprile 2025, rappresenta un punto di svolta nella complessa relazione tra diritto di critica e tutela della dignità dei lavoratori. La vicenda trae origine dal licenziamento di un dipendente, identificato come A. L. S., in seguito a un’aspra contestazione nei confronti dell’Amministratore Delegato (AD), F. L., per la decisione di organizzare una riunione in presenza durante il periodo pandemico.
Secondo quanto emerso, A. L. S. espresse il proprio dissenso attraverso una serie di email particolarmente critiche, contestando la presunta violazione dei protocolli anti-covid. La situazione precipitò quando A. L. S. inviò un esposto al Comitato anti-covid e al Presidente del CDA, sollevando preoccupazioni in merito a presunte “molestie” e “disagi” causati dall’AD. L’azienda, ritenendo tali azioni lesive della propria immagine e del rapporto di fiducia, procedette al licenziamento del dipendente.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ribaltò le precedenti sentenze, accogliendo il ricorso di A. L. S. e giudicando il licenziamento illegittimo. La Suprema Corte riconobbe la veemenza delle critiche espresse dal dipendente, ma sottolineò che esse erano strettamente connesse alla gestione dell’attività lavorativa in un contesto di emergenza sanitaria. Inoltre, la Corte valorizzò la segnalazione al Comitato anti-covid come un atto di whistleblowing, meritevole di protezione in quanto volto a denunciare presunte irregolarità interne.
La sentenza si inserisce in un quadro più ampio, caratterizzato da una crescente attenzione al ruolo dei sindacati e alla loro capacità di esprimere critiche costruttive nei confronti delle politiche aziendali. In un periodo storico segnato da incertezze economiche e continue trasformazioni del mercato del lavoro, il diritto di critica sindacale assume un’importanza ancora maggiore. La vicenda solleva interrogativi fondamentali sui confini tra dissenso legittimo e comportamenti lesivi, e sulla necessità di bilanciare la libertà di espressione con la tutela della dignità e dell’onore.
L’articolo 21 della Costituzione Italiana sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, un principio che si estende anche all’ambito lavorativo e al diritto di critica dei sindacalisti. Tuttavia, tale diritto non è illimitato e deve essere esercitato nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e pertinenza. La Cassazione, in diverse occasioni, ha ribadito la necessità di un equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela della reputazione altrui.
I limiti del diritto di critica: continenza formale e sostanziale
La sentenza della Cassazione si basa su un’analisi approfondita dei principi giuridici che regolano il diritto di critica, con particolare attenzione al concetto di “continenza”. Tale concetto si articola in due aspetti fondamentali: la continenza sostanziale, che riguarda la veridicità dei fatti narrati, e la continenza formale, che concerne le modalità espressive utilizzate.
La continenza sostanziale implica che la critica, per essere considerata legittima, deve basarsi su fatti reali e verificabili. Non è sufficiente che la critica sia animata da buone intenzioni, ma è necessario che essa trovi fondamento in elementi oggettivi e riscontrabili. In caso contrario, si rischia di sconfinare nella diffamazione o nella calunnia, che costituiscono reati punibili dalla legge.
La continenza formale, invece, riguarda il modo in cui la critica viene espressa. Anche se i fatti narrati sono veritieri, la critica può essere considerata illegittima se viene espressa in modo offensivo, denigratorio o lesivo della dignità altrui. La Cassazione ha chiarito che non è consentito utilizzare espressioni volgari, insultanti o gratuite, che non siano strettamente necessarie per esprimere il proprio dissenso. La critica deve essere sempre costruttiva e finalizzata al miglioramento della situazione, e non alla mera aggressione verbale.
Un altro elemento importante da considerare è il contesto in cui la critica viene espressa. La Cassazione ha sottolineato che l’offensività di una singola parola o frase deve essere valutata tenendo conto del contesto complessivo della comunicazione. Uno scambio di email infuocato, ad esempio, può essere valutato diversamente rispetto a un’esternazione pubblica e premeditata. Inoltre, la Corte ha stabilito che la soglia della continenza in uno scambio epistolare può essere superata soltanto qualora l’intera corrispondenza si traduca in un attacco immotivato e pretestuoso all’onore di terzi.
Oltre alla continenza formale e sostanziale, la Cassazione ha richiamato anche il principio di pertinenza, che implica che la critica deve essere rilevante rispetto all’oggetto della contestazione. Non è consentito, ad esempio, esprimere critiche che non abbiano alcun collegamento con l’attività lavorativa o con le politiche aziendali. La critica deve essere sempre finalizzata alla tutela dei diritti dei lavoratori o al miglioramento delle condizioni di lavoro, e non alla mera polemica personale.

- È confortante vedere che la Cassazione tutela i lavoratori... 😊...
- Licenziare per critica? Un'azienda fragile e autoritaria... 😠...
- Il whistleblowing come dovere civico: ma siamo pronti... 🤔...
Il ruolo del whistleblower e la tutela del dissenso
La sentenza della Cassazione attribuisce un ruolo di primo piano alla figura del whistleblower, ovvero colui che segnala irregolarità o illeciti all’interno dell’azienda. La Corte ha riconosciuto che la segnalazione effettuata da A. L. S. al Comitato anti-covid rientrava in tale categoria, e che pertanto meritava una particolare tutela.
Il whistleblowing è un’attività fondamentale per garantire la trasparenza e la legalità all’interno delle aziende. Chi segnala irregolarità spesso si espone a rischi di ritorsioni o discriminazioni, ed è quindi necessario che la legge lo protegga adeguatamente. In Italia, il decreto legislativo n. 24 del 2023 ha introdotto una disciplina organica del whistleblowing, prevedendo una serie di misure a tutela dei segnalanti.
Tuttavia, la tutela del whistleblowing non è illimitata. Il segnalante deve agire in buona fede e deve avereReasonable grounds to believe che le informazioni segnalate siano veritiere. Inoltre, la segnalazione deve essere effettuata nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dalle policy aziendali. In caso contrario, si rischia di incorrere in responsabilità disciplinari o addirittura penali.
La sentenza della Cassazione, nel valorizzare il ruolo del whistleblower, sottolinea l’importanza di proteggere il dissenso e la libertà di espressione all’interno delle aziende. Un ambiente di lavoro in cui i lavoratori si sentono liberi di esprimere le proprie opinioni e di segnalare le irregolarità è un ambiente più sano, trasparente e produttivo.
È importante che le aziende promuovano una cultura del dialogo e del confronto, in cui le critiche siano viste come un’opportunità di miglioramento e non come una minaccia. Le aziende dovrebbero dotarsi di procedure interne per la gestione delle segnalazioni, garantendo la riservatezza e la protezione dei segnalanti. Inoltre, le aziende dovrebbero formare i propri dipendenti sui diritti e doveri in materia di whistleblowing, in modo da promuovere una cultura della legalità e della trasparenza.
Verso un nuovo equilibrio tra diritti e doveri
La sentenza della Cassazione n. 10864/2025 rappresenta un passo importante verso un nuovo equilibrio tra diritti e doveri nel mondo del lavoro. La sentenza ribadisce l’importanza del diritto di critica sindacale, ma ne sottolinea anche i limiti e le responsabilità. La sentenza valorizza il ruolo del whistleblower, ma ne precisa anche le condizioni e le modalità di esercizio.
La sentenza invita le aziende a promuovere una cultura del dialogo e del confronto, in cui le critiche siano viste come un’opportunità di miglioramento e non come una minaccia. La sentenza invita i sindacati e i lavoratori a esercitare il diritto di critica in modo responsabile e costruttivo, nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e pertinenza.
In definitiva, la sentenza della Cassazione rappresenta un invito a trovare un punto di equilibrio tra la tutela della dignità dei lavoratori e la garanzia della libertà di espressione. Un equilibrio difficile da raggiungere, ma essenziale per costruire un sistema di relazioni industriali giusto ed equilibrato, in cui i diritti di tutti siano rispettati.
La riflessione che emerge da questa sentenza è che il diritto di critica, pur essendo un pilastro della democrazia, richiede un esercizio consapevole e responsabile. La linea di demarcazione tra dissenso legittimo e comportamento lesivo è spesso sottile e richiede una valutazione attenta del contesto, delle modalità espressive e delle intenzioni del soggetto criticante.
Considerazioni finali: l’arte del bilanciamento nel diritto del lavoro
Nell’intricato scenario del diritto del lavoro, l’arte del bilanciamento tra diritti e doveri si rivela una costante sfida. La sentenza della Cassazione che abbiamo analizzato ne è un esempio lampante. Permettetemi una digressione amichevole: come un funambolo che cammina su un filo sospeso nel vuoto, il legislatore e l’interprete devono costantemente calibrare le proprie scelte per evitare cadute rovinose.
Una nozione base di legale che si ricollega al tema è quella di “buona fede contrattuale”, un principio cardine che impone alle parti di un rapporto di lavoro di comportarsi in modo leale e corretto, sia nella fase di negoziazione che in quella di esecuzione del contratto. La buona fede, in sostanza, richiede di tenere conto degli interessi dell’altra parte e di non abusare del proprio potere contrattuale.
Ma se volessimo spingerci oltre, potremmo introdurre il concetto di “abuso del diritto”, una figura giuridica più complessa che si verifica quando un soggetto, pur esercitando formalmente un diritto, lo utilizza in modo distorto e contrario alla sua funzione sociale. L’abuso del diritto, nel contesto del diritto del lavoro, potrebbe configurarsi quando un datore di lavoro licenzia un dipendente per motivi pretestuosi, nascondendo in realtà una volontà ritorsiva o discriminatoria.
La sentenza della Cassazione ci invita a riflettere sul ruolo del diritto come strumento di mediazione tra interessi contrapposti. Il diritto non è un’entità astratta e immutabile, ma un prodotto sociale che si evolve nel tempo per rispondere alle esigenze della collettività. La sfida, oggi più che mai, è quella di costruire un sistema di relazioni industriali che sia al tempo stesso efficiente, equo e rispettoso della dignità umana. Un sistema in cui la critica, intesa come motore di progresso e miglioramento, non sia soffocata dalla paura di ritorsioni, ma incoraggiata e valorizzata come espressione di una cittadinanza attiva e consapevole.