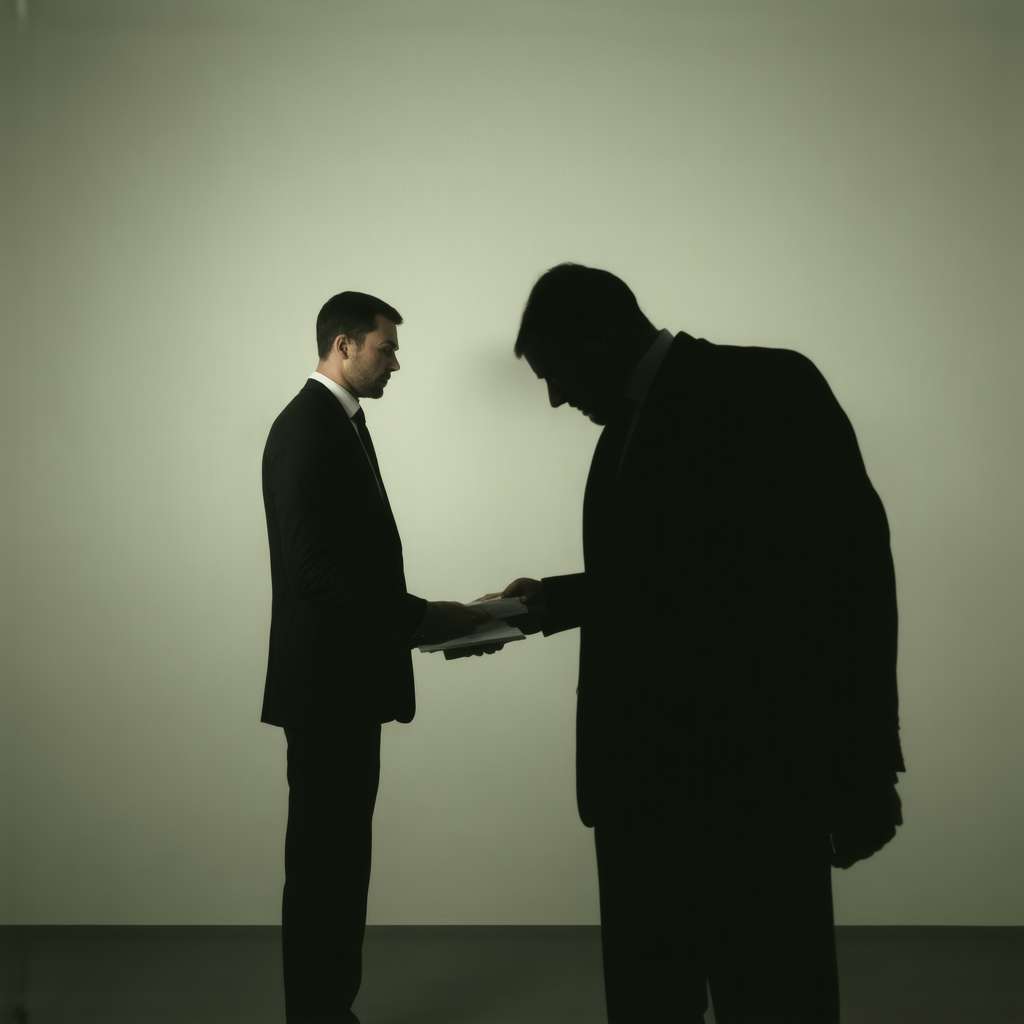E-Mail: [email protected]
- Proroga coefficienti redditività per forfetari: utilizzo ATECO 2007 in attesa di ATECO 2025.
- CU autonomi: termine inoltro spostato al 30 aprile dal 2026.
- IVA acquisti intracomunitari: versamento entro il 16 del secondo mese successivo.
- Reddito concordato: aliquote ordinarie dal 43% (IRPEF) e 24% (IRES) se superati 85.000 euro.
- Sanzioni: conciliazione in Cassazione, sanzioni al 60% del minimo.
Il 12 giugno 2025, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 134, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, meglio noto come “decreto correttivo bis“. Questa legge introduce aggiunte e rettifiche in diversi ambiti del diritto fiscale, toccando, tra gli altri, gli enti impositori, la composizione amichevole biennale, il contenzioso tributario e le sanzioni in ambito fiscale. Le variazioni apportate puntano a snellire le procedure, a potenziare l’informatizzazione del processo fiscale e ad aggiornare il sistema sanzionatorio.
Modifiche agli adempimenti tributari e al concordato preventivo biennale
Il decreto correttivo bis introduce numerose modifiche di rilievo in tema di obblighi fiscali. Tra queste, risalta la proroga dell’uso dei precedenti coefficienti di redditività per i contribuenti nel regime forfetario, autorizzando l’utilizzo dei coefficienti di cui all’allegato n. 2 della L. 145/2018, basati sulla classificazione ATECO 2007, in attesa della creazione di nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025.
Un ulteriore cambiamento di rilievo riguarda il differimento al 30 aprile del termine per l’inoltro delle CU dei lavoratori autonomi, con decorrenza dal 2026, e lo spostamento al 20 maggio della data in cui sarà disponibile la dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA. Inoltre, l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema TS diventerà annuale, anziché semestrale, a partire dai dati relativi al 2025.
Per i contribuenti forfetari che realizzano acquisti intracomunitari, il decreto semplifica i termini di pagamento dell’IVA, stabilendo che l’imposta connessa agli acquisti di beni o servizi per i quali trova applicazione l’inversione contabile (art. 17 D. P. R. 633/1972) dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.
Il decreto interviene anche sul concordato preventivo biennale (CPB), abrogando, a partire dal 1° gennaio 2025, il Capo III del Titolo II del D. Lgs. 13/2024, il quale regolamentava l’adesione a tale istituto per i contribuenti con regime forfetario. Di conseguenza, tali contribuenti non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti inizialmente previsti.
A decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente superi gli 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicheranno le aliquote ordinarie del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES. Sono state inoltre introdotte ulteriori cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato.
Il decreto fornisce una norma di interpretazione autentica sulle cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale, specificando che, ai fini dell’applicazione di tali cause (ex artt. 11, c. 1, lett. b-quater, e 21, c. 1, lett. b-ter, del D. Lgs. 13/2024), per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda.
È stato prorogato il termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre ed è stata introdotta una soglia massima alla proposta di reddito nel CPB per i soggetti con elevata affidabilità fiscale (punteggio ISA pari o superiore a 8). In particolare, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente di oltre il 10% con punteggio ISA 10, il 15% con punteggio ISA tra 9 e 9,99, e il 25% con punteggio ISA tra 8 e 8,99.

- Finalmente semplificazioni che vanno nella direzione giusta... 👍...
- Tutte queste modifiche rischiano di creare ancora più confusione... 😒...
- Interessante la conciliazione in Cassazione: un'opportunità da non sottovalutare... ⚖️...
Digitalizzazione del processo tributario e sistema sanzionatorio
Il decreto correttivo bis interviene anche sul Testo unico della giustizia tributaria (D. Lgs. 175/2024), introducendo misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico. Tra queste, l’obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al “documento analogico detenuto dal difensore” (e non più all'”originale”), l’estensione dell’uso della PEC per le notifiche anche nel giudizio di ottemperanza e la possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.
Le modifiche al sistema sanzionatorio tributario riguardano diversi aspetti. In particolare, è stato modificato l’Allegato 1 del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, differenziando le penalità per infrazioni in materia doganale e di accise. Sono state apportate modifiche al D. Lgs. 472/1997, per quanto concerne la definizione agevolata delle penalità fiscali e le disposizioni di coordinamento, rendendo possibile il ravvedimento operoso anche in caso di parziale annullamento di provvedimenti, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali (di cui al D. Lgs. 173/2024), e all’art. 69 del compendio unico delle norme relative all’imposta di registro (D. P. R. 131/1986), introducendo una penalità pecuniaria minima per ogni tipologia di violazione contemplata dalla normativa.
Il decreto interviene anche sul D. Lgs. 218/1997, allineando la procedura di accertamento con adesione alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 13/2024, e sul D. P. R. 600/1973, in materia di recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato. Nello specifico, gli atti volti al recupero di importi inerenti a provvedimenti di carattere fiscale qualificabili come aiuti di Stato e aiuti de minimis il cui ammontare non sia determinabile nei provvedimenti di concessione, ma solo in seguito alla presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono inseriti, devono essere comunicati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno seguente a quello in cui sono stati percepiti, usufruiti o in cui si è verificata la violazione; altresì, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata inoltrata la dichiarazione.
Conciliazione giudiziale in Cassazione: una novità rilevante
Il DLgs. 81/2025 ha apportato una significativa novità alla conciliazione giudiziale in Cassazione, un istituto di notevole rilevanza che consente la definizione di ogni vertenza soggetta alla giurisdizione tributaria. Possono formare oggetto di conciliazione tutti i tributi e tutti gli atti impositivi. Il perfezionamento si concretizza non con l’effettivo versamento delle somme dovute, bensì con la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o del relativo verbale. Le somme possono essere saldate a rate senza che sia richiesta la presentazione di garanzie.
Diversamente da strumenti come la definizione tramite adesione, la composizione bonaria in sede giudiziaria può limitarsi solo ad alcune contestazioni. Nei procedimenti di primo o di secondo grado e, in seguito all’emanazione del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, anche innanzi alla Corte di Cassazione, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia per via conciliativa prima della conclusione del giudizio, in conformità a quanto previsto dagli articoli 48 – 48-ter del D. Lgs. 546/92.
È prevista la possibilità di ricorrere alla conciliazione giudiziale sia “in udienza”, nel qual caso ciascuna delle parti ha la facoltà di depositare in segreteria, entro dieci giorni liberi prima dell’udienza, un’istanza di conciliazione totale o parziale, sia “fuori udienza”, mediante la quale il funzionario e il difensore munito di procura speciale possono depositare in segreteria l’istanza congiunta senza l’applicazione di particolari limitazioni temporali.
La recente riforma fiscale ha integrato l’articolo 48 del D. Lgs. 546/92 con l’aggiunta del comma 4-bis, che, per i ricorsi notificati in Cassazione a partire dal 5 gennaio 2024, ha introdotto l’opportunità di definire la controversia anche quando il procedimento è in corso dinanzi alla Suprema Corte. Il comma 3 dell’articolo 16 del decreto correttivo interviene sul D. Lgs. 220/2023, stabilendo che l’applicazione dell’istituto della conciliazione fuori udienza decorre dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 220/2023 e si estende a tutti i giudizi pendenti in Corte di Cassazione a quella data, inclusi quelli avviati antecedentemente al 5 gennaio 2024.
Mentre in precedenza la conciliazione in Cassazione era operativa per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, ora la sua applicazione potrà essere estesa anche ai processi in corso al 4 gennaio 2024. Tale modifica ha l’obiettivo di sanare un’asimmetria presente nel sistema e, soprattutto, di contribuire alla riduzione dell’arretrato accumulato presso la Corte di Cassazione, come peraltro messo in risalto nella relazione esplicativa allegata al decreto.
La conciliazione in Cassazione si differenzia da quella prevista presso le Corti di Giustizia tributaria poiché le sanzioni devono essere corrisposte nella misura del 60% del minimo, a fronte del 40% del minimo per il primo grado e del 50% del minimo per il secondo grado. Nel contesto del processo in Cassazione, continuano a trovare applicazione le disposizioni di carattere generale. Pertanto, l’accordo di conciliazione deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, munito di procura specifica. A seconda delle circostanze, la cessazione del procedimento verrà dichiarata tramite ordinanza o sentenza, con compensazione delle spese legali. Ad ogni modo, non è consentito conciliare le porzioni dell’atto già interessate dal cosiddetto giudicato interno.
Verso un sistema tributario più equo e trasparente: riflessioni conclusive
Il “decreto correttivo bis” rappresenta un passo significativo verso un sistema tributario più equo e trasparente. Le modifiche introdotte, pur nella loro complessità, mirano a semplificare gli adempimenti per i contribuenti, a migliorare l’efficienza del processo tributario e a garantire una maggiore certezza del diritto. L’attenzione alla digitalizzazione e alla conciliazione giudiziale in Cassazione sono segnali importanti di un’amministrazione finanziaria che si evolve per rispondere alle esigenze del Paese.
Una nozione base di diritto tributario rilevante in questo contesto è il principio di legalità, che impone che ogni prelievo fiscale debba essere previsto dalla legge. Questo principio è fondamentale per garantire la certezza del diritto e per tutelare i contribuenti da prelievi arbitrari.
Una nozione più avanzata è quella di “capacità contributiva”, sancita dall’articolo 53 della Costituzione italiana, che stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità economica. Questo principio implica che il sistema tributario deve essere progressivo, ovvero che chi ha di più deve contribuire in misura maggiore.
Riflettiamo, quindi, su come queste modifiche legislative possano influenzare la nostra vita quotidiana e il nostro rapporto con il fisco. Un sistema tributario più semplice e trasparente può favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contribuire a creare un clima di maggiore fiducia tra cittadini e istituzioni.